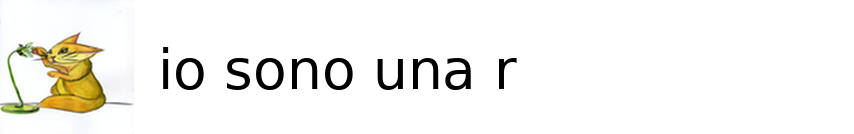Anita. Mi sono sempre piaciuti i nomi con la A. Non perdono tempo, sono i primi della Classe, come me. Sì, perché chi si è disturbato a conoscermi veramente come il mio compagno, Mattia, mi recrimina principalmente questo: che, a me, non piace arrivare seconda. Ma, scusate, a chi piace?
Eppure, non è solo per puro spirito competitivo. È che a me piace fare le cose fatte bene. È il mio modo per esprimere al Mondo il mio QI sopra la media senza risultare saccente, arrogante o, nella migliore delle ipotesi, solo antipatica. Credo sia la forma di mimetismo che ho scelto per non dare troppo nell’occhio, troppo presto. Una specie di finta preda che batte i predatori più prepotenti che puntualmente mi sottovalutano. Questo meccanismo di caccia apparentemente perfetto ha tuttavia una grossa falla. Che sono stata così brava a metterlo in scena, da aver convinto anche me stessa. Genuinamente convinta, sino al midollo. Sino ad oggi.
“I risultati sono il frutto del duro lavoro”. Questo è quello che mi ha sempre insegnato papà, fin da quando ero molto piccola. Bella fesseria. Ho lavorato anche settantadue ore di fila con pause quasi inesistenti eppure sono finita in cassa integrazione come tutti gli altri che hanno per lo più campeggiato al caffè in area break tutto il tempo. E, dopo pochi mesi, in azienda hanno consegnato un bel biglietto diretto per il treno della disoccupazione. Qualcosa non ha funzionato. È possibile che papà si sia sbagliato? Lui è una A. Un Alberto. Le A non sbagliano. Alberto è un creativo con una frammentazione dell’attenzione che ho visto in pochissime persone nella mia vita, tipica delle menti creative. Un individualista, poco interessato al parere degli altri, quanto intento all’affermazione del proprio. Presente verso di me sempre e comunque, con overdose periodiche di razionalità per esimermi dal diventare come lui, perso fra una tavolozza e un tracciato tecnico da una vita. Ci ho pensato a lungo, quasi quarant’anni, e credo di averlo semplicemente mal interpretato. Sono io che l’ho frainteso perché, molto semplicemente, non sono lui. Anzi, probabilmente sono il suo opposto.
Ieri passeggiavo verso Porta Romana con Carlotta, una ex mia collega. Aveva sbagliato strada da almeno due isolati, ma non era importante. Carlotta non capiva come potessi essere così disinteressata alla lotta impari in atto fra lei e il suo navigatore del telefono. O forse solo come potessi fidarmi del suo orientamento. Mentre gli altri non lo facevano. Proprio io, che ai suoi occhi ero sempre stata una guida precisa e meticolosa. “Un cane da pastore”. Le ho detto così, dal niente, e lei mi ha guardata stranita. Poi ha capito e mi ha raccontato la storia del cane di una sua amica che, nel cortile di casa, ha organizzato tutti gli ospiti al centro del prato senza che nemmeno che se ne accorgessero. Con cura e discrezione. Sono così: se non occorre, non intervengo. Osservo e, semplicemente, raddrizzo leggermente la traiettoria con micromovimenti. Lascio che la vita continui, seduta a qualche metro, con gli occhi chiusi in una fessura senza che nessuno possa davvero dire se siano così per il sole o persi in un sorriso. Io sono questo. E non lo sapevo. Del resto, non sono una A. Sono una R, Rebecca. Una R che ha cercato per tutta la vita di essere una A. Fin da quando avevo cinque anni e andavo al parco con la mamma. Lì, e per strada, raccontavo letteralmente a tutti con entusiasmo delle mie avventure con Anita.
Anita era ma mia migliore amica. Insieme facevamo giochi mirabolanti con le forme geometriche colorate. La sera, la mamma, ci faceva mettere tutto in ordine e riporre i giochi nel cesto di metallo della Coca-Cola. Che nascondevamo dietro la tenda che dava sulla porta a vetri del balcone da cui guardavamo per ore la gente passare frettolosa lungo il centro storico di Milano. Succedeva sempre appena prima di cena. Prima che la mamma riempisse il piatto di carne o pesce, in base al giorno della settimana. E di piselli. Era importante, per me ed Anita, che il piatto fosse totalmente coperto di quelle piccole sfere verdi. Poi, a poco a poco, forchetta dopo forchetta, scoprivamo la stampa di Braccio di Ferro impressa sul fondo. Sempre la stessa, sempre il medesimo stupore divertito. Non finivamo mai il piatto, ma era la nostra regola per mangiare. Come quella della mamma era di finire la minestra prima del secondo. La nonna diceva che sembravo una reduce di guerra, per il fatto di volere sempre il piatto traboccante di cibo. Tipico di chi ha fatto la fame. Non sapevo cosa fosse un reduce di guerra e nemmeno cosa fosse una staffetta partigiana, eppure la nonna lo era stata davvero e sapeva bene di cosa stesse parlando. Nemmeno Anita me l’aveva mai detto cosa significasse. Eppure, lei, doveva saperne tante di cose. A ripensarci oggi, il nome Anita mi ricorda tanto Anita Garibaldi. Da dove l’avevo pescato? Forse Anita ero sempre io, una parte di me che non riusciva ad esprimersi dentro e l’ha fatto fuori. Dislocandosi dalla mia persona per affermarsi. Mi piace indugiare un istante sull’idea di poter essere un’Anita Garibaldi contemporanea. Che ama la natura, fa il bagno nuda indifferente al giudizio e alle male lingue della gente. Che con la frase “devi essere mia” abbraccia il destino di un amore d’improvviso e indissolubile come quello con Giuseppe Garibaldi. Sono abbastanza convinta che, a cinque anni, non sapessi nemmeno chi fosse questa donna. A dirla tutta a cinque anni non sapevo proprio niente e, per questo, sapevo tutto.
Anita non usciva con noi al parco. Non ci accompagnava da Marchesi a comprare le torte per le ricorrenze, anche se a me piaceva tanto andarci. Non ci accompagnava nemmeno sotto casa ad aspettare papà. Anita non si faceva vedere nemmeno dalla mamma e, mentre io ero con lei, lavorava assiduamente con le sue compagne per garantire solidità, ordine e cibo al formicaio. Anita era una formica, la mia formica. Immaginaria. E quando smetteva di lavorare sodo per garantire il risultato al gruppo, veniva a giocare con me e mi ricordava chi ero.
Quando tornavamo a casa, era sempre vicino al cesto della Coca-Cola ad aspettarmi. Fino al giorno della mia prima elementare. Avevo così tante cose da raccontarle, ma quando sono tornata non c’era. Non l’ho mai più vista da allora. Non è nemmeno venuta a trovarmi a seguito del mio trasferimento nel casale di famiglia e mi sentivo spesso sola. Passavo la maggior parte del tempo a giocare da sola nel fienile, nascosta nell’angolo nero dietro alle balle di fieno che puzzava ancora di bruciato. Nel fienile che i fascisti avevano bruciato dopo aver avuto la soffiata che i nonni vi nascondevano i partigiani di passaggio. Lì mi sentivo più onesta. Ma ho sempre pensato che Anita non mi avesse perdonato di aver iniziato a giocare con Valentina dopo la scuola. Pettinavamo e vestivamo le Barbie per interi pomeriggi. Ma non ero veramente io. Era una bugia che solo io e Anita conoscevamo: non mi sono mai piaciute le bambole. Così l’ho dimenticata, come fanno tutti i bambini quando crescono e diventano qualcun altro.
Mi sono dimenticata di lei fino alla scorsa settimana. Quanto Mattia, dopo aver osservato per un tempo durato circa due capitoli di un romanzo una striscia ordinata e meticolosa di formiche incorniciare la cucina e dirigersi verso i biscotti per la colazione, ha rotto il silenzio: “…se è per la cosa dell’animalismo, le uccido io. Non è salutare lasciarle qui”. Ho chiuso il libro come se fossi stata colpevole di un crimine grave e inaspettatamente scoperta. L’ho guardato attonita mentre lui mi sorrideva bonariamente. Ho provato a reggere la difesa delle formiche basandola sul genocidio di massa, sui troppi cuoricini che avrebbe fermato e sul fatto che anche il vicino dava fastidio eppure non mi aveva proposto di liberarcene. Però poi ho ceduto e l’ho lasciato fare, perché aveva ragione. Poco prima di andare a letto, mentre ancora pensavo alle formiche ammucchiate in piccoli cumuli di cadaveri a terra e negli angoli, mi è tornata in mente Anita. “Matti, da piccola avevo una formica immaginaria, Anita”. Mattia mi ha sorriso e mi ha detto “Ma è bellissimo, perché non scrivi la storia di Anita? Così la sapranno tutti!”. Ricordo di aver annuito, mentre mi baciava sulla testa e mi stringeva forte.
Mattia non solo non mi aveva presa per pazza, ma aveva ragione. Era arrivata l’ora che Anita facesse ritorno. E mente ne scrivevo, tornavo ad essere una bambina di cinque anni che raccontava a tutti della sua migliore amica immaginaria. E diventavo me stessa, mentre una piccola formica, questa volta vera, percorreva le righe del mio quaderno come fossero strade, circumnavigava con minuzia e precisione le parole che si componevano senza sosta come fossero fiumi dopo aver rotto gli argini e, ogni tanto, si fermava a compiacersi che finalmente avevo capito. Almeno così mi è parso guardandola.

Anita tornava e
mi ricordava chi ero